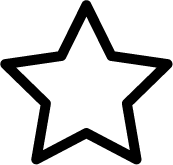12 marzo 2020
L’appassionante dilemma del “vaffa”
Nel momento che attraversiamo ci sarebbero questioni più serie di cui occuparsi piuttosto che quella del problema esistenziale se il “vaffa” possa costituire un valido marchio comunitario. Ma tant’è: la Corte di Giustizia con la sentenza del 27 febbraio 2020 (causa C‑240/18 P), si è dovuta occupare di questo problema.
Tale Constantin Film Produktion ha presentato una domanda di registrazione del segno denominativo «Fack Ju Göhte» come marchio dell’Unione europea per diversi prodotti e servizi che ha generato una serie di provvedimenti negativi nelle precedenti istanze (esaminatore, V Commissione di ricorsi, Tribunale Unione Europeo) perché contrario al “buon costume” di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento.
La norma dice infatti che sono esclusi dalla registrazione (...) f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume. «Fack Ju Göhte» sarebbe la trascrizione fonetica dell’espressone di lingua inglese «Fuck You (Göhte)», equivalente al nostro “vaffanculo”. Da qui, il dilemma giuridico se il marchio contestato sia o meno conforme al buon costume, che giustamente la Corte distingue dall’ordine pubblico. Già, ma secondo chi e in quale contesto?
Un fatto è assodato: il pubblico rilevante è quello germanofono (tedesco e austriaco), per cui occorre fare riferimento alla sensibilità di quelle genti, sensibilità che non è quella degli inglesi, “poiché la sensibilità nella lingua madre è potenzialmente maggiore rispetto a quanto avviene in una lingua straniera” (§ 68). Applicato il principio al nostro Paese, il pubblico italiano percepirebbe “vaffanculo” (equivalente dell’espressione inglese), secondo la sensibilità che gli è propria, e quindi come una originale rivendicazione libertaria di leghista memoria ovvero un modo, non propriamente elegante, per mandare a quel paese una persona. Un’espressione ormai corrente e comunemente accettata? Credo che la risposta dipenda dal contesto.
Ma nel caso in esame bisogna pensare, sentire e percepire «Fack Ju Göhte» secondo i tedeschi (per semplificare), il che mi risulta piuttosto difficile. Ma anche qui si tratta di valutare correttamente, e quindi oggettivamente, il contesto, che diviene la questione centrale nella motivazione della sentenza della Corte.
La Corte non ha avuto problemi nel descrivere questo contesto nello straordinario successo e notorietà in Germania della pellicola cinematografica dal titolo omonimo destinata agli adolescenti, che non avrebbe sollevato alcuna reazione. Nessuno – a quanto pare – si sarebbe sentito disturbato dal significato di quel titolo, chiaramente associato all’equivalente anglosassone, né avrebbe avuto niente da ridire in proposito. La Corte, quindi, ne ha tratto la conclusione che il pubblico rilevante tedesco avrebbe accettato che «Fack Ju Göhte» , "come marchio” (§ 69), non è una espressione contraria al buon costume: “nonostante l’assimilazione dei termini «Fack ju» all’espressione inglese «Fuck you», il titolo della commedia citata non è stato percepito come moralmente inaccettabile dal grande pubblico germanofono” (§ 68) . Altre circostanze sosterrebbero tale assunto.
Va detto, per la precisione, che la Corte è stata molto accurata nell’intento di fornire una interpretazione di primo livello dell’art. 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, stante i pochi e contraddittori precedenti in materia, ricordando i principi di buon governo della disposizione. Di fronte alle argomentazioni sollevate puntualmente dall’EUIPO – e in misura minore dal richiedente – e che trovo per larga parte convincenti, la sentenza non evita tuttavia l’insorgenza di alcuni dubbi.
Si ha l’impressione, infatti, che la specificità del contesto considerato porti alla sovrapposizione tra due piani normativi diversi, quello della libertà di espressione con quello del diritto di marchio.
Preliminarmente, vorrei osservare che la trascrizione fonetica ipotizzata dalla Corte è cosa diversa dalla translitterazione, l'operazione consistente nel trasporre i grafemi di un sistema di scrittura nei grafemi di un altro sistema di scrittura (generalmente un alfabeto), e questo indipendentemente dalla pronuncia delle due lingue. I due sistemi di scrittura devono dunque essere equipollenti.
Nella fattispecie, invece, ci troviamo di fronte ad un avere propria alterazione morfologica del segno verbale che, a prescindere dall’elemento estraneo Göhte, rimanda ad un segno verbale, dichiaratamente diverso. Tant’è vero che la corretta versione linguistica di «Fack Ju Göhte» sarebbe «Fick Dich», per quel poco che ne so di tedesco.
La verosimiglianza del link associativo non escludeva pertanto la necessità di esaminare se quell’alterazione comportasse o meno una percezione diversa dei due segni a confronto. Non mi sembra quindi del tutto irrilevante il rilievo che la valutazione, come marchio, della dicitura «Fack Ju Göhte» avrebbe dovuto tenere in considerazione ai fini della percezione anche il povero Goethe/Göhte, coinvolto innocentemente in questa sporca faccenda. Circostanza quest’ultima che, come notato dalla V Commissione di ricorso, già di per sè “poteva rappresentare un livello aggiuntivo di violazione del buon costume“ (cfr. la dottrina tedesca della illiceità dell’indebita appropriazione del patrimonio culturale della nazione rappresentato dai grandi personaggi storici o notori).
Ho detto prima che la Corte ha giustamente distinto il concetto del buon costume dall’ordine pubblico. Non ha però considerato che l’art. 7, paragrafo 1, lettera f), ha la stessa ratio, ratio che è diversa da quella del marchio, omettendo qualsiasi approfondimento in tema. `
Nel marchio la funzione rilevante ai fini dell’attribuzione del diritto di esclusiva è quella di contraddistinguere prodotti e servizi proveniente da un’impresa invece che da un’altra, evitando confusione sul mercato.
Viceversa, la ratio dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è di individuare ed escludere i segni di cui debba necessariamente essere impedito l’uso commerciale, bensì di evitare la registrazione di marchi quando la concessione di un diritto di esclusiva sarebbe contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita dal pubblico di riferimento come rivolta direttamente contro le norme morali fondamentali della società. In altri termini, non si può permettere che i soggetti espandano i propri obiettivi imprenditoriali tramite marchi che offendono taluni valori fondamentali della società civile.
In sostanza, l’interesse tutelato dalla norma è quello generale della Collettività, teso a salvaguardare i suoi valori costituenti e fondativi. Ne è una conferma che in tutti gli ordinamenti statuali la tutela del buon costume viene declinata e trova il suo parallelo della disciplina del diritto penale d’odine pubblico contro l’osceno ed il comune senso del pudore.
Quei valori trovano, infatti, riscontro nei diritti fondamentali delle Costituzioni nazionali e – come espressamente richiama la sentenza stessa (§ 56) – nell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ma la tutela in questione non riguarda il marchio, bensì la libera espressione del pensiero (nella fattispecie, l’adozione di una formula gergale per intitolare un film).
Queste osservazioni e la corretta interpretazione della norma di cui si discute evidenziano che il diritto di marchio, come tutti i diritti c.d.speciali, deve cedere di fronte alla normazione di grado superiore dei principi fondamentali del diritto, costituzionalmente garantiti, nell’ovvio rispetto della gerarchia delle fonti interpretative. Anche l’Avv. Generale ammette che siamo su due piani normativi diversi (§ 90 delle sue conclusioni), ma non sembra cogliere la contraddizione nel sostenere la sovrapposizione tra i loro.
Questo è il senso da attribuire alla stessa giurisprudenza comunitaria richiamata dal richiedente e dall’EUIPO, secondo cui la contrarietà o meno di un marchio all’ordine pubblico o al buon costume deve essere stabilita in base alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto. Non si tratta dunque di un approccio astratto al problema, ma del riconoscimento della diversità della ratio all’art. 7, paragrafo 1, lettera f). che, in ragione della sua ratio, esige un’interpretazione restrittiva.
Il che non esclude affatto che come marchio il segno nella sua applicazione vada contestualizzato, tenga conto cioè di tutte le circostanze attinenti ed afferenti ai casi di specie.
A riguardo, stante la presenza immanente dell’interesse generale nella ratio della norma di cui si discute, non può non lasciare perplessi l’estensione delle reazioni di un pubblico in prevalenza adolescenziale – tratte induttivamente si badi bene – di fronte ad una pellicola cinematografica ed il suo titolo, alla intera collettività del popolo tedesco. In realtà il vero problema, che sembra sfuggire alla Corte, è di natura linguistica: quello di accertare come e quando una parola o espressione verbale perde la sua connotazione semantica originale per entrare a far parte della lingua corrente e del suo vocabolario, come nel caso tipico delle parolacce e delle espressioni gergali, un po’ come suggerisce l’analogia con la volgarizzazione del marchio. In questo quadro non si capisce proprio cosa c’entra il grande Wolfang. Mi pare di buon senso affermare che il fatto che le parole "Fack Ju" siano state usate per il titolo del film non è indicativo dell’accettazione sociale delle parole di cui trattasi.
Insomma, con il dovuto rispetto per la Corte di Giustizia, io qualche dubbio ce l’avrei.
Che poi il dilemma sul ‘vaffa’ resti, onestamente non lo trovo appassionante.
_______________________________________________________________
Commenta e segui la discussione su