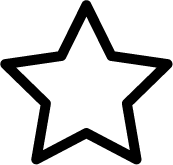11 settembre 2014
Cassazione civile, sez. III, 11 settembre 2014 , n. 19161 [Diritto d'autore - Negozi giuridici - Collegati, complessi, misti - Vendita di PC e licenza d'uso di sistema operativo - Collegamento negoziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze]
Diritto d'autore - Negozi giuridici - Collegati, complessi, misti - Vendita di personal computer e licenza d'uso di sistema operativo - Collegamento negoziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer. (Rigetta, Trib. Firenze, 30/07/2010)
Fonte: CED
SENTENZA
(Presidente: dott. Alfonso Amatucci - Relatore: dott.ssa Roberta Vivaldi)
sul ricorso 6975-2011 proposto da:
HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL (...), in persona del procuratore speciale Avv. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERDINANDO EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRIA 20, presso lo studio dell'avvocato CERZA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIURCINA MARCO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2526/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 30/07/2010 R.G.N. 19651/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato CARLO SANTORO per delega;
udito l'Avvocato CLAUDIO CERZA;
udito l'Avvocato MARCO CIURCINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel dicembre 2005 P.M. conveniva in giudizio la Hewlett-Packard Italiana srl (HP), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di quanto da lui pagato per le licenze d'uso del sistema operativo preinstallato "Microsoft Windows XP Home Edition", nonchè del software applicativo "Microsoft Works 8" fornito insieme con il notebook da lui contestualmente acquistato.
La Hewlett Packard si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso che - sulla base della corretta interpretazione delle condizioni generali della licenza d'uso sottoposte all'accettazione del P. al comparire della schermata di primo avvio del notebook - l'eventuale restituzione del prodotto e del relativo prezzo di acquisto non poteva concernere esclusivamente il software in questione, dovendo necessariamente riguardare quest'ultimo in una con l'hardware acquistato, con il quale formava un unico prodotto integrato; ipotesi per la quale essa si era già dichiarata disponibile al ritiro ed al rimborso integrale del prezzo di hardware e software.
Con sentenza n. 5384/07 l'adito giudice di pace di Firenze accoglieva la domanda e condannava Hewlett-Packard srl a pagare all'attore la suddetta somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese.
Interposto appello, interveniva la sentenza n. 2526/10 con la quale il tribunale di Firenze rigettava il gravame, compensando le spese del grado.
Avverso tale sentenza viene da Hewlett-Packard Italiana srl proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ai quali resiste con controricorso il P.; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso Hewlett-Packard deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - violazione degli artt. 1362, 1321 e 1325 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Ciò perchè il giudice di appello, violando il criterio letterale di interpretazione del contratto, avrebbe travisato la previsione di rimborso contenuta nelle condizioni generali della licenza d'uso preinstallata sul notebook; in realtà integrante non già un suo obbligo contrattuale di ricevere dall'utente la restituzione del (solo) software e di restituirgliene il prezzo, bensì l'onere di questi (allorquando non avesse accettato le condizioni della licenza d'uso "cliccando" sulla relativa casella a video) di prendere contatto con essa casa produttrice per ottenere informazioni sulle modalità e condizioni di restituzione e rimborso dell'intero prodotto (dato dall'insieme di hardware e software).
Con il secondo motivo di ricorso Hewlett-Packard si duole di violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., nonchè di contraddittoria motivazione; posto che il tribunale, dopo aver riferito il suo obbligo di ritiro e rimborso del solo software ad una determinata clausola della licenza d'uso di asserita natura contrattuale, non avrebbe poi rilevato che il contratto contenente tale clausola non era vincolante nei suoi riguardi posto che, in ogni caso, esso non venne concluso proprio a causa della mancata accettazione da parte del P..
Con il quarto motivo di ricorso Hewlett-Packard si duole di violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e dei "principi sul collegamento negoziale", oltre che di omessa ed insufficiente motivazione, sotto il profilo che: - l'affermazione del diritto dell'acquirente di ottenere il rimborso del solo software restituito non terrebbe conto del fatto che questi, pur potendo reperire sul mercato un PC privo di sistema operativo, scelse purtuttavia di acquistare il notebook in oggetto ben sapendo che su di esso vi era preinstallato il software Microsoft assoggettato a licenza d'uso; - tra contratto di vendita e licenza d'uso sussisterebbe un collegamento negoziale in forza del quale la mancata accettazione della seconda priverebbe di effetti il primo, con conseguente diritto dell'acquirente di procedere alla restituzione integrale di hardware e software, non soltanto di quest'ultimo.
p. 1.2 Questi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perchè tutti basati - nella prospettiva ora della violazione normativa, ora della carenza motivazionale sull'erronea interpretazione della clausola di riferimento contenuta nella cd. "EULA Compaq"; vale a dire, nel contratto di licenza con l'utente finale relativo all'utilizzo del software di sistema Microsoft- Windows preinstallato sul notebook acquistato dal P..
Va premesso - ad escludere al contempo l'inammissibilità del ricorso e la contravvenzione ai limiti del sindacato di legittimità - che le censure in esame mirano in effetti ad ottenere l'affermazione in questa sede di una ricostruzione della volontà negoziale delle parti diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito. E tuttavia tale affermazione viene qui sostenuta sul presupposto che il giudice di merito sia incorso, da un lato, in violazione di diritto nell'erronea applicazione delle specifiche disposizioni che presiedono, ex artt. 1362 c.c. e segg., all'interpretazione del contratto; e, dall'altro, in motivazione carente, e soprattutto contraddittoria, nell'argomentare la sussistenza a carico di Hewlett-Packard di un obbligo di natura contrattuale in realtà inesistente.
E' dunque proprio l'articolazione delle censure attraverso la prospettazione di questi due concorrenti vizi decisionali ed argomentativi ad escludere che il vaglio di legittimità, così richiesto, si risolva nella sollecitazione di una mera riconsiderazione di aspetti fattuali della vicenda riservati, in quanto tali, al giudice di merito.
Si è in proposito affermato che: "in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006; in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12946 del 04/06/2007, ed altre).
Ora, nel caso di specie vengono a ben vedere in considerazione entrambi gli aspetti di censurabilità evidenziati da questo orientamento giurisprudenziale.
Nel senso che la decisione del giudice di merito è qui sindacata non solo, come detto, sotto il profilo della violazione di specifiche norme di diritto di natura interpretativa, e della carente o contraddittoria motivazione (cd. "prima fase"); ma anche sotto quello ("seconda fase") del corretto inquadramento (o sussunzione) della volontà delle parti, così individuata, nell'ambito normativo e di effettività giuridica ad essa più appropriato; segnatamente, come meglio si dirà, per quanto concerne il disconoscimento da parte del giudice di merito degli effetti propri del collegamento negoziale asseritamente instaurato dalle parti con la clausola in oggetto (se correttamente intesa ed applicata).
p. 1.3 Ciò posto, la previsione EULA in questione (riportata in ricorso) così recita nelle parti qui rilevanti: "Microsoft Windows XP Home Edition. Contratto di licenza con l'utente finale per il software Microsoft. Il presente contratto di licenza con l'utente finale (è) un contratto intercorrente tra l'utente (una persona fisica o giuridica) e il produttore ("produttore") del computer o di un suo componente ("hardware") presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto o i prodotti software Microsoft identificati nel certificato di autenticità ("COA") accluso all'hardware o nella documentazione associata relativa al prodotto ("software")"; (...) "Installando, duplicando o comunque utilizzando il software, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente contratto.
Qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto non potrà utilizzare o duplicare il software e dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso" (...); "Licenza per il prodotto software. Nel presente contratto il termine computer viene utilizzato per indicare l'hardware, laddove l'hardware sia un computer o, qualora l'hardware sia una componente del computer, il computer nell'ambito del quale opera l'hardware"; (...) "Software come componente del computer - Trasferimento. Questa licenza non potrà essere condivisa, trasferita o utilizzata contemporaneamente su computer diversi. Il software (è) concesso in licenza con il computer come un prodotto singolo integrato e potrà essere utilizzato esclusivamente con il computer.
Se il software non è accompagnato dall'hardware, l'utente non potrà utilizzare il software".
Il giudice di merito (sent., pag.3) ha ritenuto che tale clausola riveli "due distinte vicende negoziali: quella relativa al computer (hardware) inteso come macchinario, e quella relativa al programma informatico ivi preinstallato (software). Una simile ricostruzione discende dalla considerazione che hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili, oggetto di due diverse tipologie negoziali (...)". Dallo sdoppiamento di oggetto e negozi, il tribunale ha tratto convincimento circa l'effettiva sussistenza dell'obbligo contrattuale del produttore (Hewlett-Packard) di ricevere dall'utente finale, rimborsandogliene il relativo prezzo, la restituzione non necessariamente del prodotto integrato di hardware e software, ma anche soltanto del software preinstallato.
La soluzione così accolta non incorre nelle doglianze qui dedotte.
L'adozione del criterio interpretativo letterale consente di mettere a fuoco due importanti punti fermi nella delimitazione soggettiva ed oggettiva della clausola.
Sotto il primo aspetto (delimitazione soggettiva), non è fondatamente dubitabile che il contratto di licenza (denominato non a caso "EULA Compaq") intercorra tra, da un lato, l'utente finale e, dall'altro, il "produttore"; intendendosi per tale, come testualmente si desume dalla parte definitoria della clausola in esame, "il produttore del computer o di un suo componente (hardware) presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto o i prodotti software Microsoft identificati nel certificato di autenticità (COA) accluso all'hardware o nella documentazione associata relativa al prodotto software". La controparte contrattuale dell'utente finale deve dunque identificarsi, anche per quanto concerne la licenza d'uso del software preinstallato, nel produttore del computer e dunque, nella specie, in Hewlett-Packard. Tra utente finale e casa di produzione del software contenente il sistema operativo (Microsoft) non intercorre pertanto alcun rapporto contrattuale. E ciò ben si spiega, in considerazione del fatto che si è qui in presenza non già di un software commercializzato direttamente da Microsoft (alla stregua di quanto, pure, potrebbe accadere nella vendita diretta di licenze "full" o "retail" all'utente finale), bensì di un software relativo ad un sistema operativo che viene preinstallato sul personal computer dalla casa produttrice di quest'ultimo, ed in forza di condizioni economiche e licenze di vendita che vengono trattate, a monte della grande distribuzione, in forza di accordi commerciali su vasta scala direttamente stipulati tra la casa produttrice del software (Microsoft) e le principali case produttrici dell'hardware (cd. OEM - Originai Equipment Manufacturer), tra le quali certamente si annovera il gruppo Compaq-Hewlett-Packard. Ne consegue che, sulla base della clausola contrattuale in esame, è il produttore- concessionario Hewlett-Packard, e non Microsoft, che l'utente finale che non accetti le condizioni di licenza deve "contattare prontamente" in vista della "restituzione del prodotto o dei prodotti" e del rimborso del prezzo "in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso". Va d'altra parte considerato che è proprio in forza di quegli accordi commerciali che l'originaria licenza Microsoft viene ad assumere i caratteri contrattuali e tecnici (questi ultimi, nei limiti di adattabilità e personalizzazione del software di sistema all'hardware che lo ospita) di "licenza-OEM"; come tale facente esclusivo riferimento allo specifico produttore di hardware che ne abbia convenuto con Microsoft le condizioni generali di preinstallazione e diffusione sulle proprie macchine.
Venendo con ciò al secondo aspetto (delimitazione oggettiva), la distinzione operata dal giudice di merito nel ricostruire l'effettiva volontà contrattuale delle parti, lungi da risultare in contrasto con le norme di cui agli art. 1362 c.c. e segg., è rispondente tanto al criterio letterale quanto a quello incentrato sulla natura e sull'oggetto del contratto. Ciò nel senso dell'attribuzione al software preinstallato - fatto oggetto non di vendita ma di licenza d'uso - della rilevanza di bene a sè stante, così come evincibile sia dall'impiego alternativo del numero plurale (restituzione "del prodotto o dei prodotti"; espressione tanto più significativa ove ad essa si contrapponga concettualmente la singolarità dell'hardware- PC), sia dalla testuale definizione del software concesso in licenza con il computer "come prodotto singolo", ancorchè integrato con quest'ultimo. Il richiamo al carattere di "integrazione" non muta la conclusione, dal momento che è lo stesso contratto (par. 1.2) a rimarcare come esso si risolva nella preclusione per l'utente finale di utilizzare quel software di sistema (contrassegnato dal codice di autenticità) su un PC diverso da quello sul quale è stato preinstallato in conformità alla licenza OEM. Il che, all'evidenza, vuoi dire che quel software di sistema non può essere utilizzato su un altro PC (cosa che, se avvenisse, scardinerebbe la stessa ragion d'essere dell'accordo di privativa stipulato dal produttore con Microsoft), ferma restando la possibilità tecnica che quel PC possa essere invece utilizzato con un diverso sistema operativo.
L'integrazione tra software e hardware, in altri termini, non si fonda su un'esigenza di natura tecnologica ma unicamente commerciale.
Ciò perchè, sul piano strettamente tecnologico, è pacifico (la circostanza è riconosciuta anche dalla società ricorrente, la quale ha infatti "rimproverato" al P. di non essersi rivolto al mercato dei notebook assemblati, o comunque vergini, cioè privi di sistema operativo preinstallato) che il PC o notebook potesse funzionare anche con un sistema operativo diverso da quello preinstallato. L'affermazione contenuta in taluni atti di causa secondo cui il requisito dell'integrazione dovrebbe intendersi in senso cogente posto che, senza il sistema operativo, il PC altro non costituirebbe che un inutile marchingegno, non coglie dunque nel segno; perchè non da conto della possibilità che, ferma restando l'ovvia indispensabilità funzionale del sistema operativo, quest'ultimo venga installato direttamente dall'utente con ricorso a software libero e gratuito (open source), ovvero a software proprietario (anche Microsoft) del quale egli già detenga regolare licenza d'uso. Del resto, sempre nell'ambito della ricostruzione della effettiva intenzionalità delle parti, non può sottacersi il fatto che in situazioni come la presente - ed a differenza di quelle in cui il problema della integrazione è ab origine superato dal fatto che, entro un'unica piattaforma informatica, il produttore del software di sistema sia anche il produttore dell'hardware per esso concepito e ad esso dedicato - l'utente finale è mosso all'acquisto sulla base principalmente delle specifiche tecniche del nuovo hardware; il che trova anche riscontro obiettivo nell'assoluta preponderanza del valore economico di quest'ultimo nella formazione del prezzo finale di mercato del "bene informatico" genericamente inteso.
p. 1.4 Esclusa la sussistenza di ostacoli tecnologici alla considerazione frazionata dei due prodotti, vi è da chiedersi se tale considerazione sia in ipotesi impedita da ostacoli negoziali.
Anche su questo aspetto la decisione del giudice di merito appare immune dai vizi contestati.
A detta della ricorrente (particolarmente, nel secondo e quarto motivo di ricorso), tra contratto di vendita del prodotto unitariamente inteso e licenza d'uso del sistema operativo sussisterebbe un vero e proprio collegamento negoziale, tale per cui la mancata accettazione da parte dell'utente finale delle condizioni della seconda priverebbe di effetti, per ciò soltanto, anche il primo. Con l'ulteriore conseguenza che, nell'esercizio del suo pentimento, il consumatore non potrebbe ottenere lo scorporo del sistema operativo, ma unicamente - appunto a causa del venir meno degli effetti dell'operazione complessiva - il rimborso dell'intero prezzo previa restituzione integrale e dell'hardware e del software.
La tesi del "simul stabunt simul cadent" non trova qui fondamento, non sussistendo adeguati elementi volti a dimostrare che i due contratti in oggetto siano stati voluti dalle parti (e non vi è dubbio che l'accertamento del collegamento negoziale si risolva in una determinata ricostruzione della volontà delle parti) nell'ambito di una combinazione strumentalmente volta a realizzare uno scopo pratico unitario (atto a fungere da causa concreta dell'intera negoziazione), specifico, autonomo ed ulteriore rispetto a quello ad essi singolarmente attribuibile.
Vero è invece che, nel caso in questione: - la clausola contrattuale in oggetto attribuisce, come detto, rilevanza autonoma ad hardware e software, riconoscendo anche a quest'ultimo la natura di "prodotto";
- scopo precipuo del compratore era di acquistare non già "quel" sistema operativo, bensì "quello" specifico hardware-PC; - la volizione del compratore si è, per tale ragione, incentrata sulla compravendita, non già sulla licenza d'uso che egli sarebbe stato richiesto di sottoscrivere al primo avvio del computer, e della cui esistenza, specialmente se non particolarmente ferrato in materia informatica, poteva essere finanche ignaro al momento dell'acquisto (con buona pace di una volontà di collegamento che, per rilevare, non potrebbe che essere comune).
Si è affermato (Cass. n. 7255 del 22/03/2013) che il collegamento contrattuale non da luogo ad un autonomo e nuovo contratto, essendo invece un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi; e, più specificamente (Cass. n. 11914 del 17 maggio 2010, ed altre), che: "affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale".
Orbene, nella fattispecie non è dato trarre alcun elemento - e di ciò il giudice di merito ha dato compiutamente conto - circa l'effettivo perseguimento da parte dei contraenti "di un fine ulteriore" autonomo e trascendente rispetto agli effetti tipici separatamente riconducibili, per un verso, alla compravendita del notebook e, per l'altro, all'utilizzo di un determinato sistema operativo. Il quale non è componente indissolubile nè "qualità essenziale" del computer, ma opera dell'ingegno di autonoma considerazione; verso la cui adozione l'utente viene sì sospinto, ma solo sul piano della sollecitazione ad un auspicato comportamento commerciale, non già all'adempimento di un obbligo negoziale, men che meno di rilevanza causale travalicante quella del contratto suo proprio.
L'acquisto del computer non implica l'obbligo di accettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita e l'azzeramento dell'intera operazione; e qualora l'utente esprima, all'avvio del computer, una manifestazione negativa di volontà, l'effetto del mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto nel cui ambito quella dichiarazione di volontà è stata suscitata: vale a dire la licenza d'uso.
Ciò esclude, in definitiva, che la combinazione tra la compravendita dell'hardware e la licenza d'uso del software preordinata da Hewlett Packard in attuazione di accordi con Microsoft ai quali il compratore è estraneo - possa assurgere a vero e proprio collegamento negoziale.
Non varrebbe obiettare, con la società ricorrente e taluni commentatori delle sentenze del giudice di pace e del tribunale di Firenze, che la prassi commerciale (si fa l'esempio dell'acquisto di un bene complesso per eccellenza, come un'automobile) presenta ordinariamente situazioni nelle quali l'acquisto di un prodotto implica di necessità l'accettazione di tutti indistintamente i suoi componenti; sicchè non potrebbe il compratore "pentirsi" di aver acquistato non il bene nella sua interezza, ma soltanto uno dei suoi componenti (di cui offra la restituzione separata dall'insieme).
Non pare che questo argomento - di sicura suggestività - possa sovvertire la conclusione qui accolta.
E' dirimente infatti che nella presente fattispecie non si controverte affatto di recesso (o "pentimento") dell'utente finale dall'acquisizione del software e della relativa licenza d'uso bensì, più in radice, proprio della originaria mancata formazione del consenso su tale acquisizione.
E ciò deriva a sua volta dalla peculiarità insita nel fatto che soltanto nella vendita "in bundle" di hardware e software (non anche nella vendita di altri beni complessi) si richiede all'utente di stipulare, dopo l'acquisto del primo, un ulteriore e diverso contratto relativo al secondo.
Su tale presupposto, poco importa che tale ulteriore manifestazione di volontà da parte del compratore venga richiesta attraverso un tipico servizio promozionale e di agevolazione all'uso del computer, quello appunto di preinstallazione del sistema operativo, fornito dal produttore; nè che tale preinstallazione sia stata in ipotesi da questi previamente comunicata, attraverso la rete di vendita, al compratore. Atteso che la sola consapevolezza di tale circostanza da parte di quest'ultimo (quand'anche dimostrata) non equivarrebbe, di per sè, ad accettazione delle condizioni di licenza d'uso (infatti subordinata ad una adesione discrezionale e dedicata, da successivamente esprimersi con un "clic" sul forra di primo avvio del computer); nè potrebbe ingenerare in capo al compratore una sorta di obbligo "preliminare" di aderire al successivo contratto di licenza del software, sotto condizione della risoluzione dell'intera vendita.
Corretto è dunque quanto osservato dal tribunale di Firenze (sent., pag.8), secondo cui il diritto al rimborso del software deriva qui non già dall'esercizio di un recesso "parziale" ma, con la presa in consegna del bene ed il suo pagamento integrale, "dall'esecuzione anticipata di un contratto poi non concluso"; posto che "la mancata accettazione da parte del P. delle condizioni predisposte unilateralmente dall'altro contraente equivale alla mancata adesione al contratto di licenza d'uso del software, che pertanto non si è perfezionato".
Su tale condivisibile assunto, non ha pregio l'affermazione della società ricorrente (esplicitata in particolare nel secondo motivo di ricorso) secondo cui il diritto alla restituzione ed al rimborso parziale del solo sistema operativo non potrebbe qui in ogni caso spettare; in quanto previsto (se previsto) nell'ambito di un contratto improduttivo di effetti tra le parti, proprio perchè non concluso mediante l'accettazione da parte del P.. Tale argomento, basato su un sillogismo errato, tralascia di considerare che pur in ipotesi di mancata accettazione delle condizioni della licenza d'uso - e, anzi, proprio e soltanto in tale ipotesi - si attiva, a carico del produttore, la su riportata previsione negoziale, in forza della quale: "qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto (...) dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso".
In definitiva, è la stessa proposta del produttore, avente ad oggetto l'adesione alla licenza d'uso, a stabilire che, in ipotesi di mancata adesione, l'utente abbia comunque il diritto di avviare la procedura di restituzione e rimborso. Sicchè può ragionevolmente dibattersi dell'ampiezza di tale diritto (hardware e software, ovvero solo software operativo); non anche della sua effettiva sussistenza, in quanto univocamente generato - per l'ipotesi qui ricorrente di mancata accettazione - dall'offerta di adesione proveniente dalla stessa parte obbligata.
Nemmeno persuade l'argomento (sviluppato in particolare nel primo motivo di ricorso) per cui la previsione in oggetto non attribuirebbe in realtà all'utente alcun diritto al "rimborso", ma soltanto il diritto di ottenere "informazioni sulle condizioni di rimborso".
Soccorrono anche in proposito i canoni legali di interpretazione della volontà delle parti e, in particolare, quelli di buona fede;
di conservazione del contratto; di interpretazione contro l'autore della clausola; di equo contemperamento degli interessi; di maggior convenienza alla natura ed all'oggetto del contratto. Tutti convergenti nel concludere che in tanto avrebbe senso logico e giuridico porre a carico dell'utente l'onere di contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sul rimborso, in quanto tale rimborso sia effettivamente previsto e dovuto per contratto; in modo tale che le informazioni non possano che riguardare le modalità operative del reso, non già il riconoscimento potestativo ex se del diritto ad opera del produttore.
La tesi sostenuta dalla società ricorrente è però qui da disattendere, non ultimo, non soltanto perchè strutturalmente avulsa dal fenomeno del collegamento negoziale, ma anche perchè -ove accolta - condurrebbe addirittura alla nullità dell'accordo di cui è causa. Ed anche questo va detto nell'applicazione del già menzionato criterio interpretativo in base al quale gli eventuali dubbi sulla ricostruzione della volontà delle parti debbono essere risolti nel senso che il contratto o le singole clausole conservino qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Si ritiene infatti che qualora la volontà delle parti fosse davvero stata qui orientata a stabilire un collegamento negoziale tra la compravendita e la concessione in licenza d'uso - con il risultato pratico di precludere all'utente finale la facoltà di non aderire a quest'ultima trattenendo purtuttavia il computer a fronte del rimborso del prezzo del solo software rifiutato l'accordo in oggetto urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese (art. 101 Tratt. FUE, già art. 81 Tratt.Ist.CE; L. n. 287 del 1990, art. 2).
Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'"impacchettamento" alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi OEM più affermati); tra l'altro, con riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento - se non vera e propria necessità in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremmo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista.
Evenienza - a tal punto concreta da essere già stata fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antitrust USA e della stessa Commissione UE - che può essere esclusa solo interpretando la clausola in oggetto in termini di autonomia, e non di collegamento negoziale.
E cioè nel senso che chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile.
p. 2. Con il terzo motivo di ricorso Hewlett-Packard deduce violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la clausola di rimborso del solo software applicata dal giudice di merito (quand'anche effettivamente sussistente) dovrebbe purtuttavia reputarsi nulla per indeterminatezza; ciò perchè recante la previsione, a titolo di obbligazione di valuta, del rimborso di una somma indeterminata quanto a valore di mercato del software restituito.
La censura è infondata poichè la validità del contratto non deriva soltanto, ex art. 1346 c.c., dalla determinatezza del suo oggetto, ma anche soltanto dalla sua determinabilità.
Requisito, quest'ultimo, senz'altro sussistente nella fattispecie, posto che il diritto dedotto in giudizio ha ad oggetto il rimborso di un bene che le stesse parti definiscono "prodotto commerciale" dotato di autonoma rilevanza; e che usufruisce, proprio in quanto singolarmente reperibile sul mercato, di un suo valore di catalogo o listino-prezzi (agevolmente rilevabile anche attraverso i siti web specializzati). Sicchè corretto è stato il rigetto, da parte del tribunale, del motivo di appello proposto da Hewlett-Packard in ordine alla quantificazione della somma rimborsabile; trattandosi di decisione che trova conforto, in materia di vendita, nei criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 1474 c.c..
p. 3. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; posto che il giudice di merito avrebbe erroneamente condannato Hewlett-Packard a rimborsare anche il software applicativo "Works 8", nonostante che il P., sul quale gravava il relativo onere probatorio, non avesse prodotto in giudizio il pertinente contratto di licenza d'uso.
Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento.
Il giudice di merito - con valutazione di fatto qui non censurabile - ha rilevato (sent., pag.10) che la licenza del software Works 8 (pacificamente incluso nel pacchetto acquistato dal P.) non poteva essere prodotta in giudizio se non a prezzo di rimozione dei sigilli dalla confezione nella quale essa era contenuta; il che avrebbe poi pregiudicato il diritto del P. ad ottenerne il rimborso secondo le procedure di restituzione stabilite dal produttore. Nè gli estremi di tale licenza potevano dal P. essere desunti informaticamente attraverso lo stesso PC acquistato; il cui avvio era precluso dalla mancata accettazione della licenza Windows. L'accoglimento della domanda del P. anche in relazione a Works 8 è stato dunque congruamente motivato attraverso, da un lato, l'avvenuto pacifico pagamento di tale software, offerto in restituzione con integrità dei sigilli, da parte dell'attore; e, dall'altro, l'accertata inesigibilità di un comportamento avente ad oggetto la dimostrazione di una circostanza (l'esistenza e l'identificazione della licenza d'uso) ricostruibile agevolmente anche dalla stessa controparte; alla quale la relativa prova risultava anzi, sulla scorta delle appena riportate emergenze in fatto, in definitiva più vicina (Cass. n. 20110 del 02/09/2013).
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.55.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6200,00, di cui Euro 6000,00 per compenso professionale ed il resto per esborsi; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698 ![]()
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento