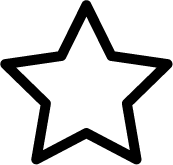19 dicembre 2016
C’è differenza tra capacità distintiva acquisita con l’uso e mera rinomanza di un marchio debole?
Nella sua pronuncia del 7 dicembre scorso (n. 25168/2016), la Cassazione afferma che non sempre il secondary meaning elimina il carattere di debolezza di un marchio debole, che pur avendo acquisito un certo carattere distintivo rimane tale, pertanto è legittima la registrazione di marchi che si differenziano dallo stesso anche solo lievemente.
La Corte di Cassazione chiarisce la portata dell’art. 13 del Codice di Proprietà Industriale e, parlando di marchi deboli e di secondary meaning, specifica che c’è differenza tra capacità distintiva ottenuta con l’uso protratto nel tempo e mera rinomanza, abbracciando tuttavia, ad avviso di chi scrive, un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigido e per certi versi teorico e astratto, che sembra non prendere in considerazione un parametro di valutazione fondamentale, ovvero la percezione del consumatore.
I fatti prendono le mosse da un marchio del settore della cosmetica divenuto ormai famoso (che quindi ha acquisito tra il pubblico un significato secondario, una sua propria capacità distintiva), ma comunque pur sempre costituito da una parola di lingua straniera di uso comune sul nostro territorio, secondo le decisioni di merito, quindi inquadrabile come marchio debole, ai sensi dell’art. 13 del Codice di Proprietà Industriale. Una società aveva infatti utilizzato il termine CLINIQUE che costituisce il marchio di una nota azienda cosmetica e, affiancando ad esso altri termini, aveva impiegato le parole così composte per identificare propri prodotti nel campo estetico.
La CLINIQUE citava in giudizio l’azienda per concorrenza sleale, agganciamento parassitario e contraffazione, ma la convenuta vinceva in primo e secondo grado e anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in suo favore.
La Cassazione ritiene che il termine CLINIQUE sia una parola straniera ormai entrata nel linguaggio comune e utilizzata spesso nel campo sanitario, quindi rientrante nella categoria dei marchi deboli.
I marchi deboli sono quei marchi privi in tutto o in parte di capacità distintiva e per questo mancanti di uno dei requisiti fondamentali perché il titolare degli stessi possa ottenere su di essi una privativa industriale. I marchi deboli, secondo il Codice della proprietà industriale, sarebbero di per sé da considerare marchi nulli, se non fosse per il fatto che con il tempo, grazie all’uso che un imprenditore ne fa, possono acquisire una propria capacità distintiva (comma 3 art. 13 CPI) e quindi un secondary meaning che tuttavia, a detta della Cassazione, non li priva della propria connotazione di debolezza.
Atteso ciò, il significato secondario acquisito da un marchio debole, come disposto dal terzo comma dell’art. 13 CPI, sanerebbe solo la nullità per difetto di capacità distintiva, ma non priverebbe il marchio del suo carattere di debolezza.
Tornando al caso di specie, secondo i giudici della Cassazione, che riprendono quanto motivato dai giudici d’appello, sebbene il marchio CLINIQUE sia sufficientemente noto a livello europeo, non ha in sé una forte capacità distintiva, ma solo una rinomanza acquisita nel tempo.
La rinomanza del marchio, consolidatosi nel tempo, lascerebbe inalterata la connotazione di marchio debole alla denominazione CLINIQUE, in quanto termine privo di per sé di capacità distintiva. Questo ammetterebbe il diritto di altre aziende di impiegare detto termine in altri marchi, senza che per questo possa sussistere una violazione della privativa industriale, in quanto qualsiasi modificazione è sufficiente a differenziare un marchio da uno preesistente se quest’ultimo è debole, in quanto, sebbene dotato di notorietà, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (da ultimo Cass. 24 giugno 2016, n. 13170).
Vero è che in dottrina in particolare per le parole straniere, talvolta, si è sostenuta la tesi secondo cui dovrebbero considerarsi sempre nulli quei marchi contenenti parole di lingua straniera di ordine denominativo o descrittivo, tuttavia questo orientamento appare palesemente superato, data la sua rigidità e teoricità, considerando che nell’ambito dei marchi, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, il parametro di valutazione da considerare è sempre quello della percezione del pubblico, che in queste pronunce sembra invece essere stato dimenticato dai giudici.
Sarà pur vero quanto affermato dalla Corte, vi è differenza tra capacità distintiva di un marchio debole acquisita col tempo e mera rinomanza, ma a parere di chi scrive, non è questo il caso. La presunta descrittività originaria del termine qui ad oggetto, sembra essere stata ampiamente superata, in quanto il segno ha acquisito con il tempo e con l’uso fatto dall’imprenditore, una sua propria capacità distintiva, un suo proprio significato, autonomo rispetto al termine originario, un secondary meaning appunto, tanto da permettere ai consumatori di determinare un collegamento diretto tra quel termine e i prodotti/servizi con l’azienda di provenienza, considerando anche le campagne e le propagande pubblicitarie svolte dalla titolare del marchio e dalla sua diffusa presenza sul mercato della cosmetica.
Per capire il senso delle mie valutazioni, è sufficiente porsi una domanda: cosa viene in mente alle donne quando qualcuno pronuncia quel termine?
Se la risposta è l’azienda produttrice di prodotti cosmetici, allora forse il marchio di cui si discorre ha acquisito una forte capacità distintiva e non una mera rinomanza acquisita con l’uso!
Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”