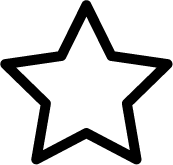12 maggio 2020
L’elogio del buon senso
L’”elogio” è molto gettonato nella letteratura. Tra i titoli che ricordo, conosciamo l‘elogio della follia (Erasmo da Rotterdam), l’elogio dell’imperfezione (Rita Levi Montalcini), l’elogio della lentezza (Lamberto Maffei), l’elogio della bruttezza (Umberto Eco), l’elogio della fuga (Henri Laborit), l’elogio dell’ozio (Bertand Russell e Robert Louis Stevenson, prima ci sarebbero Orazio, Cicerone, Ovidio e Seneca), l’elogio del diritto (Massimo Cacciari), l’elogio della vecchiaia (Paolo Mantegazza) e – modestamente – l’elogio della metafora (Stefano Sandri). Mi pare, dunque, arrivato il momento di aggiungere alla lista l’elogio del buon senso, che sta vivendo un momento di eccitata attualità nel nostro Paese.
Nel disorientamento e nella confusione generale, per salvarci dal coronavirus tutti hanno scoperto improvvisamente il valore del buon senso e ad esso si sono disperatamente aggrappati: governanti, professoroni e il sindaco di Scurcola Marsicana che ha deciso di fare come gli pare in barba ad ogni legge nazionale.
Nel mio ultimo avviso ai naviganti ho già trattato della scarsa memoria dei nostri concittadini che sembrano essersi dimenticati del diritto. Lo stesso vale per il buon senso. In proposito, se è vero che la ragione non sempre ci porta a prendere delle decisioni corrette, è altrettanto vero che ogni decisione, comprese le sentenze, non possono fare a meno di essere informate al buon senso, pena la loro inefficacia e la disaffezione da parte dei cittadini.
Ricordo che qualche anno fa mi trovai ad accompagnare in taxi all’aeroporto nientemeno che un giudice della Corte federale degli Stati Uniti, invitato a Roma a trattare il tema di quanto possa incidere su una corretta decisione il grado di competenza tecnica del giudice, ad esempio in un caso attinente ad un brevetto di invenzione. Approfittando dell’occasione, mi permisi di chiedergli: “Qual è, Your Honor, la sentenza più corretta che si possa scrivere?” Mi rispose: “Quella che il nostro tassista sarà in grado di capire”. Una risposta di semplice buon senso, appunto.
Tutto questo mi è tornato alla mente a proposito della sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2020 (causa 237/19) che, in sede interpretativa, ha sentenziato sul significato da dare al concetto di “valore sostanziale” che limita la registrabilità dei marchi di forma tridimensionale. Nel caso in esame, un’azienda ungherese aveva domandato la registrazione di questo marchio comunitario

per contraddistinguere articoli decorativi e giocattoli. Dal momento che da questa rappresentazione non si capisce niente, il Giudice ungherese ha chiesto innanzi tutto alla Corte se si poteva andare oltre la rappresentazione grafica per individuare correttamente la forma oggetto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2008/95 e la risposta non poteva che essere, ovviamente, positiva: spetta all’EUIPO e al Giudicante interpretare in modo oggettivo la domanda alla luce di tutte le informazioni disponibili, a cominciare dalla descrizione nella domanda, al netto delle intenzioni e ritenzioni meramente soggettive del richiedente, del tipo: voglio un marchio per marcare prodotti destinati ad un target extra-lusso!
Conseguentemente la Corte ci ha fatto capire che quel coso nella fattispecie era “un oggetto mono-monostabile convesso e prodotto utilizzando un materiale omogeneo, che ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile ossia, in totale, due punti di equilibrio, e la cui stessa forma fa sì che l’oggetto ritorni sempre nella sua posizione di equilibrio”.
Ciò chiarito, il punto è se nel ricorso ad altri parametri di riferimento diversi dalla sola rappresentazione grafica si possa o si debba tener conto delle reazioni del pubblico di riferimento.
Da qui, il quesito posto alla Corte:
“Se l’articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto iii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell’acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.”
In proposito, la Corte ricorda preliminarmente che “L’applicazione di questo impedimento alla registrazione si fonda su un’analisi oggettiva, intesa a dimostrare che la forma in questione esercita, in ragione delle sue caratteristiche, un’influenza così importante sull’attrattività del prodotto che il fatto di riservarne il beneficio a una sola impresa falsificherebbe le condizioni di concorrenza sul mercato interessato.” Conseguentemente, affinché si applichi l’impedimento in questione,” occorre che risulti, da elementi oggettivi e affidabili, che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è, in larga misura, determinata da una o più caratteristiche della forma dalla quale il segno è esclusivamente costituito. (§ 41).
Secondo la Corte, quindi, la disposizione in esame “deve essere interpretata nel senso che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento relativa al prodotto graficamente presentato da un segno che consiste esclusivamente nella forma del prodotto può essere presa in considerazione al fine di identificare una caratteristica essenziale di detta forma. L’impedimento alla registrazione contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta, da elementi oggettivi e affidabili, che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica.”
In buona sostanza, nel valutare il “valore sostanziale” di una forma, quando è in gioco il consumatore, si deve accertare se il suo comportamento (l’atto d’acquisto) sia essenzialmente e conclusivamente determinato dalla forma che ingloba quel valore. Prendiamo il caso che voglia comprarmi una Ferrari. All’acquisto sarò fondamentalmente indotto dalla semplice, ma definitiva considerazione che quella Ferrari è straordinariamente bella. Punto e basta. Quello che conta è il prodotto, e non il marchio come segno distintivo della sua provenienza, come è manifesto dalla formulazione del divieto. Con questo non voglio dire che nelle circostanze non potranno concorrere altri motivi (esibizionistici, ostensivi, di status symbol, di stili di vita, edonistici e altri ancora), ma che essi sono soltanto dei motivi, appunto, e non la causa, come distinguiamo in ogni transazione negoziale. Quei motivi potranno trovare giusta collocazione in altri titoli giuridici, il design, i modelli ornamentali e d’utilità o magari il brevetto o i divieti della concorrenza sleale, ma non nella disciplina dei marchi tridimensionali. Del resto sono evidenti le interconnessioni tra segno e prodotto.
Ne consegue che il ruolo, la presenza, il comportamento del pubblico di riferimento – qui il consumatore – è ineludibile nell’interpretazione del divieto di cui si discute. Qualcuno potrà anche non essere d’accordo, ma mi pare incontestabile che ci troviamo intuitivamente di fronte ad una conclusione di buon senso in cui la ragione cede all’emozione: se la forma del prodotto non mi determina al suo acquisto, non possiamo parlare di “valore sostanziale”.
Nel 2009 scrivevo: ”Una ricognizione attenta della giurisprudenza e della dottrina porta a limitare il divieto a quelle forme che in via esclusiva e definitiva inducono il consumatore all’atto d’acquisto.” (La forma che dà valore sostanziale al prodotto, in Il Dir. Ind., 01/2009, 31- 39).
Ma sono passati tredici anni! II mio tassista potrebbe ora venire a chiedermi: ma per dirci queste cose era il caso di scomodare la Corte di giustizia?
Il fatto è che quando la Corte è investita di una questione pregiudiziale deve rispondere ai quesiti che le sono posti, motivando opportunamente, anche se sono banali o ripetitivi o privi di buon senso. Tant’è vero che nella sentenza non mancano i rinvii ai propri precedenti.
Il problema dunque sta a monte, nel senso che bisognerebbe evitare che Corte venisse sommersa da una serie di quesiti che risultassero prima facie risolvibili alla luce del buon senso, in analogia un po’ a quel che succede da noi nei procedimenti di incostituzionalità, in cui le questioni da portare alla Corte non devono essere manifestamente infondate.
In conclusione, mi permetterei di suggerire ai giudici ungheresi, e non solo, di recuperare un po’ di quel buon senso che da noi si sta cercando faticosamente di non dimenticare.
_______________________________________________________________
Commenta e segui la discussione su